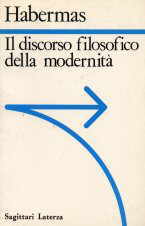|
Un progetto
incompiuto
La modernità - un progetto incompiuto,
era il titolo di un discorso che ho avuto occasione di tenere nel
settembre del 1980, quando mi venne conferito il Premio Adorno. Da allora
questo tema, assai discusso e ricco di sfaccettature, non mi ha più dato
pace. I suoi aspetti filosofici sono penetrati con forza ancora maggiore
nella coscienza pubblica tramite la ricezione del neostrutturalismo
francese, al pari del termine di «postmoderno», divenuto di moda in
seguito ad una pubblicazione di F. Lyotard. La sfida lanciata dalla
critica neostrutturalistica della ragione costituisce perciò la
prospettiva dalla quale io cerco di ricostruire passo a passo il discorso
filosofico della modernità. In tale discorso la modernità, a partire dal
tardo secolo XVIII è stata elevata a tema filosofico. Il discorso
filosofico della modernità si incontra e si intreccia in vari modi con
quello estetico. Ho però dovuto limitare il mio tema: le presenti lezioni
non tratteranno quindi il modernismo nell'arte e nella letteratura.
[...]
Torna
all'indice
Una civiltà
cristallizzata
Senza dubbio proprio gli
studi sulla modernizzazione degli anni Cinquanta e Sessanta hanno fornito
i presupposti necessari affinché l'espressione «postmoderno» potesse
entrare in circolazione anche fra gli scienziati sociali. L'osservatore
sociologico può infatti prendere tanto più facilmente congedo da
quell'orizzonte concettuale del razionalismo occidentale in cui è nata la
modernità, quanto più si pone dalla prospettiva di una modernizzazione
automatica, evolutivamente autonomizzata. Ma una volta che siano state
dissolte le connessioni interne fra il concetto della modernità e
l'autocomprensione della modernità stessa acquisita dall'orizzonte della
ragione occidentale, i processi della modernizzazione che continuano a
svolgersi per così dire in maniera automatica possono venire relativizzati
dalla prospettiva distaccata di un osservatore postmoderno. Come si
esprime Arnold Gehlen in una formula incisiva: le premesse
dell'illuminismo sono morte, soltanto le sue conseguenze continuano a
svolgersi. Da questa visuale, una modernizzazione sociale che
prosegue in modo autosufficiente il suo cammino si è separata dalle spinte
di una modernità culturale che in apparenza e divenuta obsoleta;
essa attua soltanto le leggi funzionali dell'economia e dello Stato, della
tecnica e della scienza, che, secondo quanto si dice, si sarebbero unite
in sistema sul quale non si può esercitare alcun influsso. L'inarrestabile
accelerazione dei processi sociali si presenta allora come il rovescio di
una civiltà ormai esaurita, passata in condizioni di «cristallizzazione».
Appunto Gehlen qualifica come «cristallizzata» la civiltà moderna, perché
«le possibilità in essa insite hanno sviluppato tutte le loro risorse
fondamentali. Sono state scoperte e accettate anche tutte le
contropossibilità e tutte le antitesi, di modo che ormai diviene sempre
più improbabile operare modificazioni nelle premesse [...]. Se si tiene
presente questa idea, si percepirà la cristallizzazione anche in un ambito
tanto straordinariamente mosso e variopinto come è quello della pittura
moderna». Dato che «la storia delle idee è conclusa», Gehlen può
constatare con sollievo «che noi siamo arrivati alla post-istoria», e
consigliare, con le parole di Gottfried Benn: «Conta sulle tue risorse».
Questo commiato neoconservatore dalla modernità non si riferisce
alla sfrenata dinamica della modernizzazione sociale, bensì all'involucro
di un'autocomprensione culturale della modernità, che sembra ormai
superato.
Torna
all'indice
L'approccio anarchico
L'idea della postmodernità si presenta invece in
tutt'altra forma politica, e cioè in quella anarchica, presso quei
teorici i quali non ritengono che si sia verificato uno sganciamento fra
la modernità e la razionalità. Anch'essi reclamano la fine
dell'illuminismo, oltrepassano quell'orizzonte della tradizione razionale,
a partire del quale un tempo la modernità europea ha compreso se stessa -
e anch'essi si sistemano nella post-istoria. Ma a differenza dal commiato
neoconservatore quello anarchico si riferisce alla modernità nel suo
complesso. Mentre sprofonda quel continente concettuale che sorreggeva
il razionalismo occidentale di Max Weber, la ragione fa conoscere il suo
vero volto, e viene smascherata come soggettività assoggettante e al
contempo soggiogata, come volontà di impadronimento strumentale. La forza
sovversiva di una critica alla maniera di un Heidegger o di un Bataille,
che strappa il velo della ragione dal volto di una pura volontà di
potenza, deve al contempo far vacillare quella gabbia d'acciaio in cui si
è oggettivato socialmente lo spirito della modernità. In questa
visuale la modernizzazione sociale non può sopravvivere alla fine della
modernità culturale, dalla quale è scaturita - essa non potrà resistere a
quell'«immemorabile» anarchismo, nel cui segno si delinea il postmoderno.
Queste due varianti della teoria del postmoderno, comunque si
differenzino fra di loro, prendono entrambe le distanze da quel
fondamentale orizzonte concettuale in cui si è formata l'autocomprensione
della modernità europea. Ambedue le teorie del postmoderno pretendono
infatti di essere uscite da questo orizzonte, di averlo lasciato dietro di
sé come orizzonte di un'epoca passata. Ora il primo filosofo che abbia
sviluppato un chiaro concetto della modernità è stato Hegel; se vogliamo
intendere che cosa abbia significato quell'intima relazione fra
modernità e razionalità, che fino a Max Weber era rimasta ovvia, ed oggi è
messa in questione, dobbiamo risalire ad Hegel. Dobbiamo renderci conto
del concetto hegeliano della modernità, per poter giudicare se sussista a
buon diritto la pretesa di coloro che svolgono le loro analisi in base a
premesse diverse. In ogni caso non possiamo respingere a priori il
sospetto che il pensiero postmoderno si arroghi una posizione
trascendente, mentre rimane in realtà vincolato a quei presupposti
dell'autocomprensione moderna, che Hegel ha messo in luce. Non possiamo
escludere fin da principio che il neoconservatorismo o l'anarchismo
estetizzante facciano nuovamente le prove, in nome di un commiato dalla
modernità, di una ribellione contro di essa. Potrebbe anche darsi che essi
ammantino soltanto la loro complicità con una veneranda tradizione del
controilluminismo, spacciandola per post-illuminismo.
Torna
all'indice
La
lezione di Hegel
Hegel per primo usa
il concetto della modernità in contesti storici, come concetto di
un'epoca: l'«età nuova» è l'«età moderna». Il che corrisponde al
contemporaneo uso linguistico inglese e francese: modern times e
temps modernes designano, intorno al 1800, gli ultimi tre secoli
allora trascorsi. La scoperta del «nuovo mondo», il Rinascimento e la
Riforma - questi tre grandi eventi intorno al 1500 - costituiscono la
soglia epocale fra l'età moderna e il Medio Evo. Con queste espressioni
anche Hegel circoscrive, nelle sue lezioni sulla filosofia della storia il
mondo cristiano-germanico, che a sua volta è derivato dall'antichità greca
e romana. L'articolazione ancor oggi usuale in età moderna, medio evo ed
antichità (oppure di storia moderna, medioevale e antica, che serve per
esempio a designare le cattedre di storia) poté costituirsi soltanto dopo
che le espressioni di età «nuova» o «moderna» (e di mondo «nuovo» o
«moderno») avevano perduto il loro senso puramente cronologico ed assunto
il significato oppositivo di un'epoca enfaticamente «nuova». Mentre
nell'Occidente cristiano il «tempo nuovo» aveva preannunciato l'ancora
attesa età futura del mondo, che si sarebbe avviata soltanto con il Giorno
del Giudizio - così intesa ancora nella Filosofia delle epoche del
mondo di Schelling -, il concetto profano dell'età moderna esprime la
convinzione che il futuro è già incominciato: esso si riferisce infatti
all'epoca che vive rivolta al futuro, che si è aperta al nuovo futuro. La
cesura del nuovo cominciamento si è quindi spostata nel passato, appunto
agli inizi dell'età moderna; soltanto nel corso del secolo XVIII la soglia
epocale intorno al 1500 è stata retrospettivamente concepita come tale
inizio. R. Koselleck usa come test il momento in cui il nostrum
aevum, il nostro tempo, è stato ribattezzato col nome di «nova
aetas» - l'età moderna. [...]
Torna
all'indice
La contemporaneità e
l'emergenza del presente
Il mondo
nuovo, moderno, si distingue dall'antico in quanto. si apre al futuro;
perciò il nuovo cominciamento epocale si ripete e si perpetua in ogni
momento del presente che generi da se stesso il nuovo. Spetta quindi alla
coscienza storica della modernità la delimitazione dell'«età
contemporanea» da quella moderna: all'interno dell'orizzonte dell'età
moderna il presente gode, in quanto storia contemporanea, di un valore
posizionale prominente. Anche Hegel intende il «nostro tempo» come 1'«età
contemporanea», e data l'inizio del presente a partire dalla cesura
rappresentata dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione francese per i più
pensosi contemporanei del morente secolo XVIII e dell'incipiente secolo
XIX. Con questa «splendida aurora» noi perveniamo - così pensa ancora il
vecchio Hegel - «all'ultimo stadio della storia, al nostro mondo, ai
nostri giorni». Un presente che si intende a partire dall'orizzonte
dell'età moderna, come l'attualità dell'età contemporanea, deve rieseguire
come rinnovamento continuato quella frattura che essa ha compiuto
col passato. Concordano con tutto ciò quei concetti di movimento che,
insieme all'espressione di età «moderna» o «nuova» nascono, oppure
acquisiscono il loro nuovo significato, valido fino ad oggi, nel XVIII
secolo: rivoluzione, progresso, emancipazione, sviluppo, crisi, spirito
del tempo, ecc. Tali espressioni sono divenute anche parole-chiave della
filosofia hegeliana, che chiariscono, alla luce della storia dei concetti,
il problema che si pone con la coscienza storica moderna della civiltà
occidentale, chiarito tramite il concetto oppositivo dell'«età moderna»:
la modernità non può né vuole più mutuare i propri criteri d'orientamento
da modelli di un'altra epoca; essa deve attingere la sua propria
normatività da se stessa. La modernità si vede affidata a se stessa,
senza alcuna possibilità di fuga. Il che spiega la facilità con cui la sua
autocomprensione si confonde, la dinamica dei tentativi, proseguiti senza
posa fino al nostro tempo, per «rendersi conto» di se stessa. Ancora pochi
anni fa H. Blumenberg si è visto costretto a difendere, con grande
apparato storico, la legittimità ossia il diritto proprio dell'età
moderna contro quelle costruzioni che le attribuiscono un debito
culturale verso i lasciti del cristianesimo e dell'antichità: «Non è
affatto naturale che un'epoca si ponga il problema della propria
legittimità storica, esattamente come non è naturale che essa si
concepisca in genere come epoca. Per l'età moderna questo problema è
latente nella pretesa di compiere e di poter compiere una rottura radicale
con la tradizione, e nel fraintendere tale pretesa come realtà della
storia, che non può mai incominciare di nuovo fin dal fondamento». A
conferma, Blumenberg adduce una dichiarazione del giovane Hegel: «A parte
altri precedenti tentativi, è stato riservato soprattutto ai nostri tempi
di rivendicare in proprietà degli uomini, almeno in teoria, i tesori che
sono stati dissipati in cielo. Ma quale età avrà la forza di far valere
questo diritto e di entrarne in possesso?».
Torna
all'indice
Baudelaire e il canone
estetico
Il problema di
un'autofondazione della modernità giunge alla coscienza anzitutto
nell'ambito della critica estetica, come si può vedere quando si segua la
storia concettuale dell'espressione «moderno». Il processo di separazione
dal modello dell'arte antica e avviato all'inizio del secolo XVIII dalla
celebre Querelle des Anciens et des Modernes. Il partito dei
moderni si ribella contro l'autocomprensione del classicismo francese,
assimilando il concetto aristotelico della perfezione a quello del
progresso, quale era stato suggerito dalla moderna scienza della natura. I
«moderni» mettono in questione, facendo uso di argomenti storico-critici,
il senso dell'imitazione dei modelli antichi, elaborano, contro le norme
di una bellezza assoluta e apparentemente sottratta al tempo, i criteri
del bello condizionato dal tempo o relativo, e con ciò esprimono
l'autocomprensione dell'Illuminismo francese, che si intende come un nuovo
inizio epocale. Benché il sostantivo «modernitas» (insieme alla
coppia aggettivale antinomica «antiqui/moderni») fosse già stato
adoperato in senso cronologico fin dalla tarda antichità, nelle lingue
europee dell'età moderna l'aggettivo «moderno» venne sostantivato solo
assai tardi, all'incirca dalla metà del diciannovesimo secolo, e anzitutto
di nuovo nell'ambito delle belle arti. Il che spiega perché le espressioni
«moderno» e «modernità», «modernité», hanno mantenuto fino ad oggi
un centrale significato estetico, improntato all'autocomprensione
dell'arte d'avanguardia.
Per Baudelaire a quel tempo l'esperienza
estetica della modernità si fondeva con quella storica. Il
problema dell'autofondazione si acuisce nell'esperienza fondamentale della
modernità estetica, perché qui l'orizzonte dell'esperienza del tempo si
contrae nella soggettività decentrata, che si discosta dalle convenzioni
quotidiane. Perciò l'opera d'arte moderna assume per Baudelaire una
posizione singolare nel punto in cui si incrociano gli assi dell'attualità
e dell'eternità: «La modernità è il transitorio, l'evanescente,
l'accidentale, è la metà dell'arte, la cui altra metà è l'eterno e
l'invariabile». Il punto di riferimento della modernità diviene ora
l'attualità che consuma se stessa, e che ci rimette l'estensione di un'età
di transizione, di un'età contemporanea - della durata di parecchi decenni
- costituita nel centro dell'età moderna. Il presente attuale non può più
acquistare la propria autocoscienza nemmeno dal suo opporsi ad un'epoca
ripudiata e oltrepassata, ad una figura del passato. L'attualità
può costituirsi soltanto come punto d'incrocio fra tempo ed eternità. Con
questo contatto diretto fra attualità ed eternità, il moderno non si
sottrae certamente alla sua caducità, bensì alla banalità: nella
concezione di Baudelaire esso è disposto in modo tale che il momento
transitorio troverà conferma come l'autentico passato di un presente che
ancora deve venire. Esso si dimostra come ciò che un giorno sarà
classico: «classico» è ormai il «fulmine» del sorgere d'un mondo
nuovo, che certamente non sarà stabile, perché con la sua stessa comparsa
suggella già anche la propria decadenza. Questa concezione del tempo,
radicalizzata ancora un'altra volta nel surrealismo, fonda
l'affinità fra il moderno e la moda.
Baudelaire
si ricollega al risultato della celebre controversia fra gli antichi e i
moderni, ma sposta in modo caratteristico i pesi fra il bello assoluto e
quello relativo: «Il bello è costituito da un elemento eterno,
immodificabile [...], e da un elemento relativo, condizionato [...], che è
rappresentato dal periodo, dalla moda, dalla vita culturale, dalla
passione. Senza questo secondo elemento, che per così dire è come la
glassata allettante e scintillante che rende digeribile la torta divina,
il primo elemento sarebbe insopportabile per la natura umana». Come
critico d'arte, Baudelaire nella pittura moderna pone in rilievo l'aspetto
«della bellezza fugace, effimera, della vita attuale, il carattere di ciò
che il lettore ci ha permesso di designare come la «modernità». Baudelaire
pone tra virgolette la parola «modernità»; egli è consapevole dell'uso
nuovo, terminologicamente arbitrario, di questa parola, per via del quale
l'opera autentica è radicalmente legata al momento della sua nascita;
proprio perché si consuma nell'attualità, essa può arrestare il flusso
uniforme delle banalità, violare la normalità e soddisfare per l'istante
di una fuggevole connessione fra l'eterno e l'attuale l'imperitura
esigenza di bellezza.
La bellezza eterna si svela soltanto nel
travestimento del costume temporale - una caratteristica che più tardi
Benjamin rivestirà con l'espressione dell'immagine dialettica. L'opera
d'arte moderna sta sotto il segno dell'unificazione fra l'autentico e
l'effimero. Questo carattere di presente fonda anche l'affinità dell'arte
con la moda, col nuovo, con l'ottica dello flâneur, del genio e del
bambino, ai quali manca la difesa che contro le eccitazioni offrono i modi
convenzionali della percezione, e che perciò sono esposti senza alcuna
protezione agli attacchi della bellezza, degli stimoli trascendenti
nascosti in ciò che vi è di più quotidiano. Il ruolo del dandy
consiste allora nel rovesciare con fare blasé in offensiva
questo tipo di extraquotidianità subìta, esibendola con mezzi provocatori.
Il dandy collega ciò che è ozioso e alla moda con il piacere di
stupire, senza esser mai egli stesso stupito. È l'esperto del fuggevole
diletto dell'istante, dal quale sgorga il nuovo: «Egli cerca quel qualcosa
che io mi permetto di designare come la "modernità"; non c'è infatti
termine migliore per esprimere l'idea in questione. Per lui si tratta di
svincolare dalla moda ciò che essa può contenere di poetico nello storico,
e di eterno nel fuggevole». [...]
Torna
all'indice
Soggettività, libertà,
riflessione
Hegel per primo eleva a
problema filosofico quel processo di distacco della modernità dalle
suggestioni normative del passato, che non rientrano in essa. Certamente,
nel corso di una critica della tradizione che accoglie in sé esperienze
della Riforma e del Rinascimento, e reagisce agli inizi della moderna
scienza della natura, la filosofia moderna, dalla tarda scolastica fino a
Kant, esprime già anche l'autocomprensione della modernità. Ma soltanto
alla fine del XVIII secolo il problema dell'autoaccertamento della
modernità si acuisce a tal punto, che Hegel può vederlo come
problema filosofico, e precisamente come il problema fondamentale
della sua filosofia. Hegel concepisce come «fonte del bisogno della
filosofia» l'inquietudine derivante dal fatto che una modernità priva di
modelli deve stabilizzarsi uscendo dalle scissioni che essa stessa ha
provocato. Quando la modernità si desta alla coscienza di se stessa, nasce
un bisogno di autoaccertamento, che Hegel intende come il bisogno di
filosofia: egli infatti ritiene che la filosofia si trovi dinanzi al
compito di cogliere il proprio tempo e cioè per lui l'età moderna, nel
pensiero. Hegel è convinto di non poter affatto acquisire quel concetto
che la filosofia si forma di se stessa, indipendentemente dal concetto
filosofico della modernità.
Anzitutto Hegel scopre nella
soggettività il principio dell'età moderna. Partendo da tale
concetto egli spiega la superiorità del mondo moderno e al contempo il suo
carattere di epoca percorsa da crisi: esso si esperisce infatti come il
mondo del progresso e al contempo dello spirito estraniato. Perciò il
primo tentativo di portare al concetto la modernità nasce insieme ad una
critica della modernità.
Secondo Hegel l'età moderna è caratterizzata
in generale da una struttura dell'autorelazione, che egli chiama
soggettività: «Il principio del mondo moderno in genere è la libertà della
soggettività, per cui tutti gli aspetti essenziali, che esistono nella
totalità spirituale, si sviluppano, pervenendo al loro diritto». Hegel,
quando definisce la fisionomia dell'età moderna (o del mondo
moderno), spiega la «soggettività» con la «libertà» e la «riflessione»:
«La grandezza del nostro tempo è che esso riconosce la libertà, la
proprietà dello spirito di essere in sé presso di sé». In questo contesto
l'espressione «soggettività» comporta soprattutto quattro connotazioni: a)
individualismo: nel mondo moderno la peculiarità infinitamente
particolare fa valere le proprie pretese; b) diritto alla critica:
il principio del mondo moderno esige che ciò che ciascuno deve riconoscere
si mostri a lui come un che di legittimo; c) autonomia dell'agire:
è proprio del mondo moderno che noi ci consideriamo responsabili di quello
che facciamo; d) infine, la filosofia idealistica stessa: Hegel
considera come l'opera dell'età moderna, che la filosofia colga l'Idea che
sa se stessa.
Gli eventi storici decisivi per l'attuazione del
principio della soggettività sono la Riforma, l'Illuminismo
e la Rivoluzione francese. Con Lutero la fede religiosa è divenuta
riflessiva, il mondo divino nella solitudine della soggettività si è
mutato in qualcosa di posto da noi. Contro la fede nell'autorità della
predicazione e della tradizione, il protestantesimo afferma l'autorità del
soggetto che attinge soltanto al proprio giudizio: l'ostia è considerata
ancora soltanto come un pezzo di pane, la reliquia ancora soltanto come
ossa. In seguito la proclamazione dei diritti dell'uomo e il Code
Napoléon hanno considerato quale fondamento sostanziale dello Stato il
principio della libertà del volere, contro il diritto storicamente
constatato: «Si è ritenuto che il diritto e l'eticità si fondino
sull'attuale terreno della volontà dell'uomo, mentre prima erano imposti
esteriormente soltanto come comandamento di Dio, scritto nel Vecchio e nel
Nuovo Testamento, o presente nella forma di diritto particolare in vecchie
pergamene, quali privilegi, o nei trattati».
Torna
all'indice
|
esercitazioni |
|
autovalutazione |
home page
www.
lastoria.org |