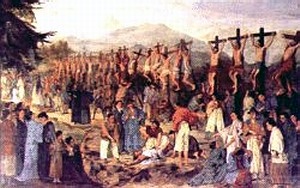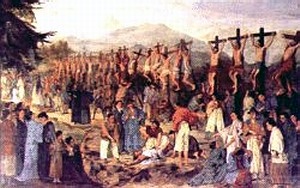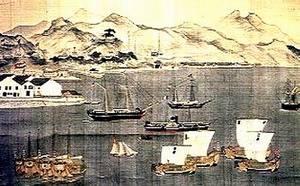Quando intorno alla metà del Cinquecento i primi
mercanti occidentali, accompagnati dal vessillo della corona portoghese,
raggiunsero le coste giapponesi, furono ben presto seguiti da alcuni audaci
missionari. In una nazione pur dilaniata da decenni di conflitti intestini, essi
trovarono un ambiente culturale che nel corso dei secoli aveva reso propria
consuetudine l'assimilazione degli influssi culturali provenienti dall'esterno.
In pochi anni le comunità cristiane superarono un numero di centomila aderenti,
su una popolazione di circa dodici milioni di persone, una cifra destinata a
triplicare nel momento della loro massima espansione. La minaccia della
colonizzazione dell'aggressivo regno iberico e il timore della nascita di nuovi
conflitti religiosi, cui le isole giapponesi non erano estranee, posero però le
basi per una crescente diffidenza, nei confronti della nuova religione, da parte
del ricostituito potere centrale, che nel primo quarto del XVII secolo sarebbe
culminata in una delle più grandi tragedie della cristianità. I primi religiosi
occidentali a raggiungere le coste giapponesi erano stati, quasi un secolo
prima, il 15 agosto del 1549, tre frati gesuiti, tra i quali anche Francesco
Saverio, a bordo di un vascello
wako. Gli
wako erano gruppi di
corsari che, a partire dalla metà del XIII secolo, con l'indebolirsi
dell'autorità centrale, salpando principalmente dall'isola di Tsushima, a metà
strada fra Kyushu, la più meridionale fra le grandi isole dell'arcipelago
giapponese, e la Corea, martoriavano le coste continentali, spingendosi fino
alla Cina.
Quando la neocostituita dinastia Ming cercò di ostacolare il
commercio con le isole nipponiche, furono proprio costoro che, spesso con il
favore delle popolazioni locali, mantennero vivi gli scambi lungo lo stretto di
Corea. I loro vascelli, organizzati in flottiglie che potevano raccogliere anche
migliaia di uomini armati, furono i primi a entrare in contatto con gli
esploratori e i mercanti europei. E paradossalmente uno dei più arditi capitani
di queste formazioni, chiamato Anjiro e noto per la sua intraprendenza, si fece
carico del viaggio che avrebbe condotto Francesco Saverio, dalla Malacca, in
Giappone. Francesco Saverio era nato a Xavier, da cui il suo nome, latinizzato,
nei paesi baschi, nel 1506, ma si trasferì, ancora giovane, a Parigi, dove
frequentò l'università della Sorbona. Nella capitale francese entrò in contatto
con Ignazio di Loiola, dalle cui idee, di forte ispirazione apostolica, venne
affascinato. Nel 1540 fu tra i fondatori della
Compagnia di Gesù, ma
dopo pochi anni si trasferì nella colonia portoghese di Goa, per dare inizio ad
un'intensa opera di evangelizzazione degli abitanti di Malacca e delle Molucche,
tale da valergli il titolo di
Apostolo delle Indie. Il viaggio nelle
isole giapponesi non avrebbe che rappresentato una tappa del suo percorso,
rimanendovi per oltre due anni.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
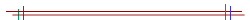 |
 |
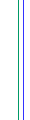 |
All'epoca di
Saverio
le strade di Kyoto
ricordavano
a stento la gloria
degli anni passati |
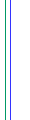 |
 |
 |
 |
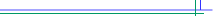 |
 |
Sbarcato
a Kagoshima, nell'estremità meridionale di Kyushu, diede inizio all'opera di
evangelizzazione compilando, in lingua giapponese, con l'aiuto, non sempre
adeguato di Anjiro, un semplice catechismo. I suoi sforzi non si dimostrarono
vani e circa cento persone accettarono il battesimo. Un anno dopo il proprio
arrivo visitò Hirado e Yamaguchi, sull'isola di Honshu, la più centrale e più
estesa di quelle che costituiscono l'arcipelago giapponese, ma il suo vero
obiettivo era Kyoto.
Kyoto, l'antica Heian, situata nella regione più
centrale di Honshu, nel 794 d.C. era stata eletta a capitale del primo nucleo di
quello che sarebbe diventato l'Impero del Sol Levante, per scelta del tenno
Kenmu, i cui discendenti regnano tuttora sul trono nipponico. Da quella data, la
presenza di una corte fissa fece sì che la città diventasse non solo il centro
economico e politico, ma anche culturale dell'arcipelago. All'epoca di Francesco
Saverio le strade di Kyoto ricordavano però a stento la gloria degli anni
passati, le guerre civili avevano trasformato la regione con una miriade di
fortificazioni, perlopiù di grosse dimensioni, e la stessa capitale era spesso
teatro di sanguinosi combattimenti. L'intento del missionario gesuita era
l'incontro con l'imperatore Gonara, la cui funzione ricopriva un ruolo ormai
puramente simbolico. Al punto che si erano dovuti aspettare oltre vent'anni,
dall'ascesa al trono, perchè si potessero reperire i fondi necessari per la
cerimonia d'incoronazione. Il religioso basco avrebbe voluto ottenere il
permesso di predicare attraverso l'intera nazione, ma, posto che tale desiderio
fosse stato concesso, quasi sicuramente il benestare del sovrano sarebbe stato
privo di qualsiasi autorevolezza. A ogni modo, il celebre gesuita non venne
ammesso al cospetto del figlio del Sole e, deluso, lasciò il Giappone per
l'India verso la fine del 1551. Di lì a poco, in rotta verso la Cina, avrebbe
trovato la morte, il 3 dicembre 1552, sull'inospitale isola di Sanciano. Posto
ad esempio per il vigore e la convinzione con cui condusse la propria opera
missionaria, Francesco Saverio venne canonizzato nel 1622. Negli anni successivi
alla partenza del frate gesuita, l'opera di evangelizzazione del Giappone non
subì però un arresto e le comunità cristiane, pur concentrate a Kyushu,
soprattutto nella fortezza di Nagasaki, erano diffuse anche lungo l'isola di
Honshu.
La nuova religione venne infatti accolta con favore anche
dall'
establishment politico, soprattutto perchè associata agli scambi
economici con il Portogallo, che introdussero i primi modelli di archibugio, sia
perchè costituiva un'alternativa al crescente potere dei templi
shintoisti e
buddhisti, spesso all'origine di conflitti
religiosi, di natura settaria, che arrecavano un notevole danno alla già
precaria stabilità interna. Nel 1563 Omura Sumitada, un
daimyo di
Kyushu, uno dei potenti signori della guerra che all'epoca controllavano
l'arcipelago giapponese, temendo la minaccia degli avversari, sempre più
prossimi ai propri territori, adottò la religione cristiana e offrì agli
occidentali il porto di Nagasaki come base per il loro commercio. La fortezza,
affacciata sull'omonima baia, lungo l'estremità nordoccidentale di Kyushu,
divenne ben presto il quartier generale della Compagnia di Gesù, sede di un
seminario per la formazione dei preti locali e di una stamperia, allestita per
la diffusione delle prime traduzioni di una serie di testi occidentali, non
necessariamente di carattere religioso, fra cui un'edizione delle
Favole di Esopo e l'
Imitazione di Cristo di Thomas à Kempis.
Il successo dei missionari fu indubbiamente merito del tatto con cui condussero
la propria azione, cercando di lavorare fra i feudatari e la nobiltà giapponese,
evitando in questo modo di essere sottoposti al sospetto di introdurre idee
sediziose. Le fasce più umili e più povere della popolazione vennero coinvolte
nel progetto di evangelizzazione solo in un periodo successivo, con l'arrivo di
religiosi di altri ordini, soprattutto Domenicani e Francescani. Grazie ai loro
sforzi le comunità divennero sempre più popolose fino a raggiungere quasi il 2
percento della popolazione, una quota sensibilmente superiore perfino ai valori
attuali. Oltretutto il cristianesimo godeva di una larga popolarità presso le
classi superiori anche grazie all'interesse verso la cultura e le tradizioni
occidentali.
 |
Takugawa
Ieyasu, i cui discendenti
avrebbero governato il Giappone fino al
1867 |
Se molte conversioni erano giustificate
con motivazioni effettivamente di carattere spirituale, altre erano invece la
diretta conseguenza di una sorta di infatuazione per i costumi dei nuovi
visitatori. Con tale spirito, oltre a interessi puramente commerciali, Oda,
passato alla storia per aver restaurato un potere centrale sull'intero
arcipelago, o almeno su buona parte, favorì l'attività dei religiosi
occidentali, principalmente spagnoli, italiani e portoghesi, garantendo loro
privilegi e concessioni. Il celebre condottiero iniziò perfino a dimostrane una
certa preferenza per la compagnia di questi uomini, dalle maniere eleganti e
istruiti, ma soprattutto estranei agli intrighi di palazzo. Il 9 giugno del 1580
Sumitada cedette perpetuamente Nagasaki all'ordine gesuita
, ma uno
degli episodi più originali della storia del primo cristianesimo giapponese fu
indubbiamente la missione in Europa del 1582, guidata da Alessandro Valignano.
Valignano era nato a Chieti nel 1539 e, dopo gli studi in giurisprudenza
all'Università di Padova, entrò nella Compagnia di Gesù all'età di 27 anni.
Incaricato di visitare le missioni in Asia, con l'eccezione delle Filippine, nel
1573, il religioso italiano giunse in Giappone per la prima volta nel 1579.
Durante il proprio soggiorno dimostrò singolari doti organizzative,
ristrutturando le missioni già presenti e fondando un seminario a Usuki e due
scuole per ragazzi a Funai e Azuchi. Fra i propri correligionari promosse lo
studio della lingua giapponese e l'adozione dei costumi locali. Quando nel 1582
si accinse a tornare in Europa lo accompagnavano quattro ragazzi, fra i 12 e i
13 anni, studenti del seminario di Arima, e un seguito di altre sedici persone.
Costoro erano incaricati di visitare le corti di Filippo II di Spagna, che in
quel tempo era anche Re del Portogallo, e Papa Gregorio XIII, in ambasciata in
nome del
Daimyo Cristiano di Kyushu, Omura Sumitada.
Costui aveva
nel frattempo adottato il nome cattolico di Bartolomeu. La spedizione ottenne
anche l'appoggio di Otomo Sorin, battezzato come Francisco, e Arima Harunobu,
Protasio, anch'essi potenti signori feudali dell'isola giapponese. Il gruppo
lasciò Nagasaki il 20 febbraio del 1582 per raggiungere le coste portoghesi solo
nell'agosto del 1584. In novembre furono accolti da Filippo II per proseguire
alla volta di Roma. Gregorio XIII si dimostrò magnanimo, elargendo doni e
emettendo una bolla in base alla quale l'attività religiosa in Giappone rimaneva
prerogativa della
Compagnia di Gesù. Pochi mesi dopo la partenza
dall'oriente della celebre missione, Oda Nobunaga, il primo
Reggente e
riunificatore del Giappone, era però caduto vittima del tradimento di uno dei
propri generali, Akechi Mitsuhide, il quale, anzichè rispettare gli ordini
convenuti aveva marciato su Kyoto e aveva sopraffatto il celebre condottiero,
uccidendolo brutalmente. Mitsuhide non fu però in grado di mantenere il potere e
a Nobunaga successe Toyotomi Hideyoshi. Costui, di umili e oscure origini, aveva
raggiunto la massima carica della nazione attraverso la carriera militare e in
un primo momento mantenne l'atteggiamento seguito dal predecessore nei confronti
delle comunità cristiane. Le quali avevano però subito un duro colpo quando, nel
1584, il clan degli Shimazu aveva occupato Nagasaki. Nel 1587 la morte colse
Sumitada e Hideyoshi, che nel frattempo aveva sconfitto gli Shimazu, si
impossessò del porto fino a poco prima controllato dai gesuiti. Hideyoshi doveva
però affrontare la difficile eredità di Nobunaga, ma per governare un paese
lacerato dalle guerre intestine e non ancora rappacificato erano necessarie non
soltanto le indubbie capacità di cui godeva, ma anche il rispetto dei propri
vassalli.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
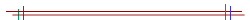 |
 |
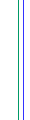 |
I Francescani
erano
giunti a Kyushu nel
1592 incuranti
del divieto
di
evangelizzazione |
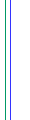 |
 |
 |
 |
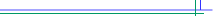 |
 |
Molti
dei quali non accettavano ben volentieri un padrone di umile estrazione, una
situazione effettivamente eccezionale all'interno di una società rigidamente
stratificata come quella giapponese. Hideyoshi cercò di creare un passato per la
propria famiglia, ma soprattutto volle recuperare l'immagine dell'antica
diarchia, ottenendo il prestigio che gli mancava da una pur formale reggenza in
nome dell'imperatore. Il quale, secondo la tradizione, discendeva da Amaterasu
Omikami, la dea del sole progenitrice di Jenmu, il leggendario primo imperatore.
Hideyoshi trovò quindi un ostacolo nella dottrina cristiana e nel 1587 emise una
serie di editti che ponevano, in maniera del tutto repentina, un arresto
all'attività missionaria dei Gesuiti. Si lasciava però assoluta libertà di
spostamento ai cristiani che giungevano in Giappone per commerciare, purché non
creassero elementi di disturbo nei confronti delle pratiche religiose
tradizionali. Ma tali disposizioni furono perlopiù disattese, soprattutto per
via dell'influenza dei
daimyo cristiani, fra i quali vi erano alcuni
dei più validi generali dello stesso Hideyoshi. In quello stesso anno Hosokawa
Tama, la terzogenita di quell'Akechi Mitsuhide che cinque anni prima aveva posto
fine alla vita di Nobunaga, ricevette il battesimo. La crescente influenza dei
Gesuiti, soprattutto sull'isola di Kyushu, non contribuì però a placare
il risentimento di Hideyoshi, cui si aggiunsero i contrasti fra i missionari
della
Compagnia di Gesù e i
Francescani. Questi ultimi erano
giunti a Kyushu nel 1592, incuranti degli editti che proibivano qualsiasi forma
di evangelizzazione, e avevano dimostrato di ottenere un largo credito fra gli
strati più bassi della popolazione. Incurante dei consigli di alcuni
daimyo, Hideyoshi diede nuovo impulso alla lotta contro il
cristianesimo nel 1597. Il 5 febbraio di quello stesso anno, a Nagasaki,
ventisei sacerdoti, sia stranieri che giapponesi, vennero crocefissi.
L'esecuzione ebbe luogo alle 10 del mattino, sulla collina di Nishizaka, alle
porte della città. Terazawa Hazaburo, fratello di Ierazawa Hazaburo, il
governatore, impartì gli ordini per la crudele cerimonia.
Le vittime, cui era
stato amputato l'orecchio sinistro, erano già stremate da oltre trenta giorni
del percorso, effettuato quasi interamente a piedi, che li divideva dal luogo
della cattura al luogo prescelto per il martirio. Fra il pubblico del macabro
spettacolo si trovavano alcuni padri gesuiti, commercianti spagnoli e
portoghesi. L'episodio, del tutto simile ai molti che hanno accompagnato la
cristianità nei primi secoli della propria storia, traeva giustificazione da un
diverbio avvenuto alcuni mesi prima, il 26 agosto del 1596 a bordo della
San
Felipe, un galeone battente bandiera spagnola. I dettagli non sono chiari,
ma sembra che quando la nave fece scalo nella baia di Urado, nella prefettura di
Tosa, sull'isola di Shikoku, il carico trasportato fosse stato confiscato in
nome del
Reggente Hideyoshi. Il capitano avrebbe poi minacciato
l'invasione del Giappone da parte di un'armata spagnola, e che tale invasione
sarebbe stata favorita dall'attività di spionaggio dei frati francescani. I
francescani, del tutto estranei a un complotto di tal genere, ritorsero le
accuse ai gesuiti, con i quali avevano più di un motivo di contrasto. Hideyoshi,
forse istigato dagli stessi gesuiti che in tal modo pensavano di allontanare per
sempre i propri rivali, diede l'ordine di arrestare sette frati francescani e
venti conversi, successivamente deportati e condannati al patibolo. Il
Reggente sarebbe però deceduto l'anno seguente e l'attività dei
missionari fu in grado di proseguire indisturbata. A Hideyoshi successe il
figlio Hideyori, ma, essendo ancora giovane, il paese veniva di fatto retto dai
luogotenenti del padre, che avevano prestato giuramento al clan Toyotomi. Le
rivalità interne sfociarono ben presto nello scontro armato e, nella battaglia
di Sekigahara, emerse la figura vittoriosa di Tokugawa Ieyasu, i cui discendenti
avrebbero governato il Giappone fino al 1867. Ieyasu in un primo tempo ristabilì
una politica tollerante nei confronti della minoranza cristiana, attratto dalle
possibilità del commercio con il Portogallo e minacciato da ben più seri
problemi, fra cui quella posta da Hideyori, pur sempre l'erede di Hideyoshi.
L'ingresso dei vascelli inglesi, cui, a partire dal 1613 fu concessa la
possibilità di approdare in qualsiasi porto dell'arcipelago, e dei mercanti
olandesi, consentì a Ieyasu di affrontare la presenza dei missionari cattolici
con maggiore libertà.
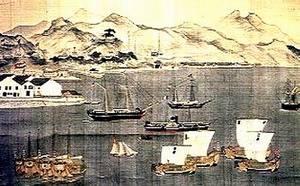 |
Il porto di
Nagasaki: nel 1584 venne
occupato dal clan degli
Shimazu |
Una lettera di Maurizio di Nassau
aveva inoltre avvertito il
Reggente che la
Compagnia di Gesù,
sotto la copertura della santità della religione, intende convertire i
Giapponesi alla propria religione, dividere l'eccellente regno del Giappone e
condurre la nazione alla guerra civile". Nel 1614 il
Reggente Tokugawa
ordinò a tutti i missionari di lasciare il paese, la maggior parte dei quali
acconsentì, ma circa quaranta, fra cui alcuni preti giapponesi, rimasero per
continuare il proprio lavoro in clandestinità. L'anno prima, Date Masamune, che
a Sekigahara aveva combattuto a fianco delle insegne dei Tokugawa ed era stato
ricompensato con i vasti domini della provincia di Sendai, aveva inviato
Hasekura Tsunenaga, un suo vassallo, a Roma, attraverso il Messico e la Spagna,
per venire ricevuto da papa Paolo V. Anche questa volta, come nel 1582, la
missione si rivelò infruttuosa perchè quando don Philip Francisco, il nome
adottato da Tsunenaga dopo che a Madrid aveva ricevuto il battesimo, tornò in
Giappone, era il 1620, le persecuzioni contro i
kirishitan, i
cristiani, avevano ripreso vigore. I maggiori provvedimenti erano stati presi
fra il 1614 e il 1615, ma gli avvenimenti più sanguinosi dovevano ancora avere
luogo. Nel 1622, la popolazione di Nagasaki assistette nuovamente al martirio di
51 cristiani, due anni dopo altri cinquanta vennero arsi vivi a Edo, l'attuale
Tokyo. Le stime parlano di circa tremila fedeli giustiziati per non aver
abiurato il proprio credo, cifra cui si devono escludere i morti per le
sofferenze patite in carcere o in esilio. Le torture cui vennero sottoposti i
cattolici raggiunsero a un tale livello di crudeltà che perfino alcuni religiosi
rinnegarono le proprie convinzioni. Per individuare la presenza di comunità
cristiane nei villaggi fu istituito lo
shumon aratamecho, una struttura
di stampo poliziesco che si rivelò molto efficiente per il controllo della vita
privata dei sudditi dell'intera nazione. Nel 1633, trenta missionari salirono
sul patibolo e nel 1637 solo cinque godevano ancora della libertà. In quello
stesso anno si consumò l'ultimo, tragico episodio dell'avventura cristiana in
Giappone.
Le persecuzioni, ma anche le pesanti tassazioni cui vennero
sottoposti gli abitanti della prefettura di Nagasaki, la sede storica
dell'attività missionaria, fu tale da spingere i contadini della penisola di
Shimabara alla rivolta. A essi si unirono
samurai e dignitari privati
del proprio rango, come pure gli abitanti dell'isola di Amakusa, in un ultimo
disperato tentativo in difesa della propria fede. L'insurrezione fu una dura
prova per Tokugawa Iemitsu, il successore di Ieyasu. L'esercito cristiano si
battè con valore, ma la sproporzione delle forze in gioco costrinse i rivoltosi
a rifugiarsi nel castello di Hara. Stremati dalla fame, il 28 febbraio del 1638,
la roccaforte si arrese dopo tre mesi di assedio. Secondo le stime negli ultimi
due giorni della battaglia 10.800 fra gli insorti morirono decapitati, altri,
fra i 5.000 e i 6.000, preferirono morire piuttosto che arrendersi. Alcuni
trascinarono con sè, nelle fiamme, i propri figli, per risparmiarli dalla furia
dei vincitori. I quali non dimostrarono alcun atto di clemenza e misero a morte
i sopravvissuti. I fatti di Shimabara spinsero la
Reggenza a irrigidire
ulteriormente i rapporti con l'esterno. Gli ultimi portoghesi presenti
sull'arcipelago vennero confinati sull'isola artificiale di Dejima, costruita
nella baia di Nagasaki fra il 1634 e il 1636. Nel 1639 vennero definitivamente
allontanati, e i soli a poter sviluppare accordi commerciali con il Giappone
rimasero gli Olandesi, ai quali, a partire dal 1641, non fu concesso che
l'approdo di Dejima. Dopo la caduta del castello di Hara la presenza cristiana
in Giappone sembrò essere stata debellata, ma proseguì clandestinamente fino a
quando, nella seconda metà del XIX secolo, la nazione non riprese i contatti con
l'esterno. Nel 1865, dopo che un gruppo di cittadini di Nagasaki si identificò
pubblicamente come cristiani, nei luoghi più remoti della nazione, dove il
potere centrale era meno efficiente, oltre 60,000 giapponesi rivelarono di non
aver mai abbandonato la religione introdotta da Francesco Saverio. Solo nel 1873
le sanzioni emanate oltre due secoli prima vennero definitivamente
abrogate.