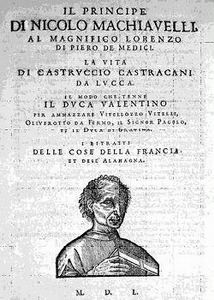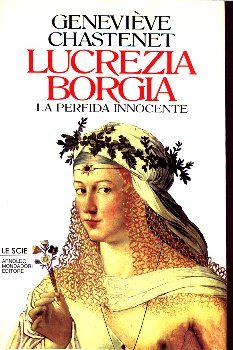Cesare Borgia è uno dei
personaggi più celebri della storia italiana del Cinquecento. La sua fama è
legata per vari versi al cognome; quello di una famiglia ricordata per l'astuzia
nel trarre benefici dal potere e per un alone di "ferocia", a volte caricata
dalla leggenda altre volte connotata da meraviglia (e per ciò stesso in parte
assolta).
Per Nicolò Machiavelli fu l'immagine del condottiero militare e,
soprattutto, del
principe italiano che avrebbe potuto
raggiungere l'obiettivo di unificare la penisola - seppure questa prospettiva,
in quel momento, esistesse soltanto nella mente di un gruppo poco omogeneo di
intellettuali - in alternativa alla galassia di regni, staterelli e signorie, in
lite tra loro e tutti, in modo diretto o indiretto, dipendenti dalle potenze
straniere di turno. In questo contesto svettava il ruolo dello Stato pontificio,
che Machiavelli dimostrò come fosse abbastanza forte da impedire che potenze
straniere unificassero l'Italia (ad esempio l'impero svevo-normanno di Federico
II Hohenstaufen), ma debole per (o senza la volontà di) cimentarsi esso stesso
nell'impresa; tanto da orientare la propria politica nel mantenimento della
divisione della penisola - utilizzando anche la propria posizione geografica che
impediva una continuità territoriale tra Nord e Sud - riuscendo a conservare
questa posizione di forza fino al 1860.
Lo scrittore politico fiorentino
accenna a fatti relativi al Borgia in vari capitoli de
Il Principe e ne
realizza una descrizione più articolata nel settimo, anche se il sistema
analitico costruito è pieno di insidie, poiché, come avviene per le valutazioni
storiche, è alto il rischio di sovrapporre modelli attuali al passato, dando per
scontato, in modo aberrante, l'esistenza di condizioni e metodi attuali nella
storia di ieri, nella convinzione, ancora più aberrante, della sua
immutabilità.
Da queste false partenze si rischia di avvolgere l'esistenza di
Cesare Borgia in una cappa opprimente di retorica nazionale, infondata dal punto
di vista storico e insopportabile per le caratteristiche estetiche, perché così
è stata resa nel corso dei tanti secoli, durante i quali, essendo la penisola in
possesso di altri stati, la
intellighenzia intendeva il compito al solo
scopo di accreditarsi nei confronti dei sovrani esteri: una retorica nazionale
che di nazionale non aveva nulla, se non l'apparenza.
Il Borgia, in quanto
condottiero, doveva essere strapieno di pragmatismo e il più possibile alla
larga dalle illusioni. Il suo fine era conquistare territori; prima per
annetterli allo Stato pontificio, il cui papa Alessandro VI era suo padre, e poi
per crearsi un suo regno. Si possono avere legittimi dubbi che questo regno si
potesse chiamare Italia e soprattutto che egli avesse dell'Italia la stessa idea
geopolitica attuale e, se sì, che intendesse applicarla. Tanti dubbi che
purtroppo la retorica, con la disinvoltura che le è propria, ha trasformato in
certezze.
 |
Alessandro VI, padre di Cesare
Borgia, fu papa dal 1492 al 1503 |
La sua
storia Cesare Borgia nasce nel 1475, da Alessandro Borgia e Vannozza
Catanei. I Borgia (Borja) erano una famiglia originaria della Catalunya, e
diedero alla Chiesa due papi. Il primo, Alonso Borgia, nato a Jàtiva (Valencia)
nel 1378, salito al soglio pontifico con il nome di Callisto III, si distinse
sul versante spirituale per la salvaguardia della dottrina, impedendo uno scisma
da parte dei boemi utraquisti, e su quello politico per l'opposizione alla
avanzata dei turchi in Europa.
Suo nipote Rodrigo Borgia, nato l'1 gennaio
1431, eletto cardinale a venticinque anni, divenne papa l'11 agosto1492 con il
nome di Alessandro VI. Durante il suo pontificato rafforzò l'ordine pubblico,
azzerò una parte del debito dello Stato, promosse una crociata contro i turchi,
decretò un anno di Giubileo, fu mecenate di vari artisti, potenziò l'università,
e con un editto sancì la spartizione del
Nuovo Continente tra Spagna e
Portogallo.
Date queste premesse, Cesare sembrava avviato alla carriera
ecclesiastica. A diciassette anni, il 31 agosto del 1492, fu nominato
arcivescovo di Valencia (ma non si recò in Spagna e non prese i sacramenti
dell'ordine), poi cardinale il 20 settembre del 1493, e nel 1495 governatore
generale e legato di Orvieto.
Nel 1496 muore Ferdinando II, re di Napoli. Non
aveva figli e il titolo passò allo zio, Federico. La incoronazione di questi fu
l'ultimo atto di Cesare Borgia come cardinale.
Subito però si ebbe il
segnale delle sue intenzioni future. Cerca (senza successo) di assicurarsi la
mano di Carlotta, principessa di Taranto, figlia del nuovo sovrano, per
diventare uno dei più potenti baroni del regno e inserirsi nel gioco della
successione al trono.
Sui motivi della rinuncia al titolo cardinalizio vi
sono un paio di versioni. La prima fa leva sul suo travaglio personale; non si
sente attratto dalla vita ecclesiastica. La seconda invece spiega la decisione
con un episodio di cronaca avvenuto nel 1498, allorché suo fratello, Giovanni,
dal 1488 duca di Gandia (il ramo che continuò la dinastia dei Borgia) e
comandante dell'esercito pontificio dal 1496, fu assassinato e non si escluse
l'ipotesi che fosse stato per volontà di Cesare.
Ma seppure si sia trattato
solo di voci, non sarebbe da scartare la possibilità che le due versioni siano
in realtà complementari: il solo sospetto sulla fine del fratello potrebbe avere
rappresentato un momento di svolta nella sua vita, portandolo all'abbandono
delle cariche ecclesiastiche che, quanto meno dal punto di vista formale,
stridevano con il suo carattere, probabilmente anche con le sue ambizioni, e
anche con il suo modo di vivere poco convenzionale che lo portava, ad esempio, a
esibirsi in corride allestiste a piazza San Pietro. Comunque sia andata, questa
vicenda oscura fu soltanto una tra quelle che contraddistinsero la sua
esistenza.
Avviene intanto un mutamento sostanziale nella politica estera
dello stato pontificio.
Nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, su incitamento di
alcuni signori - tra cui Ludovico il Moro - era entrato nella penisola italiana
occupando Firenze, Roma e, l'anno successivo, il regno di Napoli (di cui
rivendicava i diritti degli Angiò). Contro di lui si era formata una lega
composta da Alessandro VI, Ferdinando il Cattolico, Massimiliano d'Austria, che
lo costrinse a tornare indietro.
Il 7 aprile 1498 muore Carlo VIII. Essendo
deceduto, poco prima, anche suo figlio, la corona fu assegnata al cugino, Luigi
XII duca di Orleans, che inizia una politica più distensiva nei confronti di
Alessandro VI.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
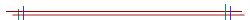 |
 |
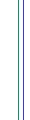 |
Il 10 maggio 1499,
Cesare Borgia
sposa Carlotta
d'Albret, sorella
del re di
Navarra |
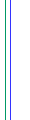 |
 |
 |
 |
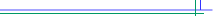 |
 |
Il
motivo fu la necessità da parte del nuovo re di annullare il suo matrimonio con
Giovanna di Valois per poter sposare Anna, regina della Britannia.
La
commissione d'inchiesta pontifica stabilì che quel matrimonio non era valido:
per mancanza di consenso, e perché non consumato.
L'1 ottobre 1498, Cesare si
reca in Francia per portare la dispensa papale a re Luigi, e una nomina a
cardinale per il suo ministro D'Amboise; ma anche per trovare una moglie di alto
rango.
Ottenuto il nuovo incarico di comandante dell'esercito pontificio, il
10 maggio 1499, Cesare sposa Carlotta d'Albret, sorella del re di Navarra
(regione a nord della Catalunya) e nipote di Luigi XII, stabilendo una alleanza
con la Francia - per la futura conquista della Romagna -, ottenendo il titolo di
pari di Francia, e il ducato di Valentinois che da allora avrebbe fornito ai
suoi contemporanei e agli storici un paio di soprannomi: il
Duca, e il
Valentino.
L'8 ottobre 1499, insieme al re francese entra a Milano.
L'inizio della collaborazione con l'esercito francese e il consolidamento delle
sue capacità di condottiero si ebbero nella guerra contro la Spagna, di cui un
episodio - la presa di Capua, nel 1501, - ispirò una tela del pittore Gaetano
Previati, dal titolo
Cesare Borgia, Duca del Valentino, a Capua, che si
trova al Palazzo di Residenza, a Forlì.
La sua prima missione fu la conquista
di alcuni territori limitrofi a quelli della Chiesa, i cui signori, con il
sostegno della dinastia aragonese del regno di Napoli, si erano resi sempre più
autonomi, tanto da indurre il papa a dichiararli usurpatori.
Nel dicembre
1499, Cesare Borgia risale la penisola verso nord-est con un esercito composto
da quattromila mercenari provenienti dalla Svizzera e dalla Guascogna (regione
della Francia sud occidentale), duemila italiani, e con il supporto di
artiglieria e di trecento arcieri fornitigli da Luigi XII. Dall'area tra il nord
delle Marche e il sud della Romagna si diresse verso la Toscana. Ad aprile 1501
aveva conquistato Imola, Forlì, Faenza, Cesena, Rimini, Pianosa, l'isola d'Elba,
Piombino. A Cesena trova il supporto di una fazione, quella dei Tiberti, contro
i rivali Martinelli.
Piombino fu conquistata il 3 settembre, utilizzando
l'assenza del sovrano Iacopo IV degli Appiani, che si era recato a Genova. Ma un
intervento diplomatico di Luigi XII costrinse i nuovi arrivati a compiere marcia
indietro. A quel punto intervenne Alessandro VI il quale riuscì a convincere gli
abitanti del principato che il loro sovrano stava per cedere l'isola d'Elba alla
repubblica di Genova, fomentando così la ribellione popolare favorevole al
Valentino.
Arrivato a Cantalupo, vicino Imola, la popolazione, considerando
inutile ogni resistenza, gli consegnò la città. Da lì passa alla conquista dei
territori circostanti: solo il castello di Dozza riuscì per un breve periodo ad
opporsi, con le truppe guidate da Gabriele del Pica, prima di essere
travolto.
A quel punto il Valentino si dirige verso Forlì, dove trova la
maggior parte della popolo schierato dalla sua parte. A contrastarlo era rimasta
Caterina Sforza che tentò fino all'ultimo di ostacolarne l'avanzata, chiudendosi
con i suoi seguaci nella Rocca di Ravaldino (una fortezza caratterizzata da
torrioni bassi cilindrici ad angolo, la cui costruzione fu completata sotto la
signoria di Pino III Ordelaffi), la quale, dopo essere stata espugnata, fu
adibita a prigione e poi polveriera dello Stato pontificio.
Caterina Sforza,
signora di Forlì, era moglie di Giovanni de' Medici e madre del futuro celebre
Giovanni delle Bande Nere. Catturata il 12 gennaio del 1500, le fu risparmiata
la vita, condotta a Roma e confinata in un convento, da cui fu liberata per
intercessione francese; stabilitasi a Firenze, morì nel 1509.
L'avanzata del
Duca avrebbe potuto continuare se le truppe francesi, alle sue dipendenze, non
avessero deciso di fermarsi, non si sa bene se per stanchezza, o per ordine
arrivato.
 |
Nicolò Machiavelli: fu
legato
di Firenze presso Cesare
Borgia |
Al ritorno a Roma fu accolto in modo
trionfale. Ottenne dal pontefice la nomina a vicario papale dei territori
conquistati e un finanziamento per il proprio esercito.
Quando non era sul
campo di battaglia stava nei suoi appartamenti: indossava una maschera nera,
scriveva poesie, e lavorava giorno e notte, mantenendo in modo costante i
contatti con i suoi luogotenenti.
Il pittore Giorgione, pseudonimo di Giorgio
da Castelfranco (tra le sue opere: la
Pala di Castelfranco nel 1504, e
il
Cristo con il Manigoldo, nella chiesa di San Rocco, del 1508), in un
ritratto lo mostra atletico, con il volto allungato, una barba non troppo folta,
il naso aguzzo, i capelli lunghi e biondi, lo sguardo attento.
Da ricordare
anche il ritratto attribuito ad Altobello Meloni (Accademia Carrara, Bergamo) e
Ritratto di Cesare Borgia, di Ignoto lombardo del '500 (Palazzo
Venezia, Roma).
Il mistero che circonda la sua figura è intensificato da una
serie di testimonianze e di cronache, di cui però non sempre si ha
certezza.
Si pensi a quanto riferiva l'ambasciatore veneziano Paolo Capello,
a proposito di quando il Valentino fece condurre nel cortile del suo palazzo
alcuni prigionieri e appostatosi ad una finestra con arco e frecce, iniziò a
centrarli uno ad uno. O alla vicenda del cardinale Michiel e di altri porporati,
ai quali, per sua volontà, secondo alcune versioni, furono tolti gli averi e poi
torturati e uccisi. E a quanto si racconta sia avvenuto a Imola nel 1501, quando
dopo un diverbio tra il
"nobile Virgilio" (forse Orsini), e un suo
soldato, Guidardello Guidardelli di Ravenna, conclusosi con il ferimento e il
successivo decesso di quest'ultimo, il Borgia ordinò la cattura e la
decapitazione dell'altro contendente.
Si può anche ricordare una lettera del
25 agosto 1501, di Agostino Vespucci - in quel momento presso la corte
pontificia - a Nicolò Machiavelli, a proposito della eredità di Giovanni Lopez,
cardinale di Capua, e delle manovre intorno a essa. Il Vespucci avanza dei dubbi
sulle cause della morte del cardinale e fa notare che questi era poco amico di
Cesare Borgia.
Il 15 luglio 1500 un gruppo di ignoti aggredisce Alfonso
d'Aragona - duca di Bisceglie e figlio illegittimo del pretendente al trono del
regno Napoli - secondo marito di Lucrezia Borgia. Alfonso d'Aragona riesce a
salvarsi, seppure riportando gravi ferite, ma il 18 agosto viene strangolato; si
ritiene da parte di una guardia del corpo del Valentino.
Ci aveva già
provato un anno prima, a Colledara (Teramo), sferrandogli, inutilmente, contro
un attacco con il suo esercito.
Poco dopo Lucrezia andò sposa ad Alfonso
d'Este, figlio del duca di Ferrara, città potente su cui lo stato pontificio
cercava di avere un controllo, tanto che tra il 1482 e l'84 si era giunti ad una
guerra tra la città - appoggiata da Mantova, dal ducato di Milano e dal regno di
Napoli - e l'alleanza formata del papa Sisto V e la repubblica di
Venezia..
Nell'ottobre del 1500, il Duca inizia una seconda spedizione contro
gli stati nemici della Chiesa e conquista i castelli laziali che appartenevano
ai Colonna e ai Savelli, due tra le famiglie più prestigiose; dopodiché si
dirige verso le Marche.
Il suo esercito adesso contava circa quindicimila
soldati, a cui erano aggregati preti, giullari e "dame di compagnia". Espugnò,
senza combattere, Rimini e Pesaro, i cui signori, Pandolfio Malatesta e Giovanni
Sforza, pensarono che, avendo poche possibilità di vincere, era inutile
azzardare una battaglia.
Il pessimismo degli avversari era rinfocolato dal
successo popolare che il Borgia
riscontrava attraversando i territori da
conquistare. Soltanto Faenza tentò di fronteggiarlo, guidata da Astorre Manfredi
e dal fratello, Giovanni, ma dovette cedere alcuni mesi dopo, nonostante l'aiuto
di Firenze - che per questo dovette versare tributi al Valentino - e di Bologna
- che dovette scendere a patti - guidata da Giovanni Bentivoglio.
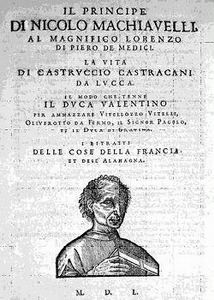 |
Il celebre testo per il
quale
Machiavelli si ispirò al Borgia |
Il
comportamento spavaldo valse comunque ai due faentini la lode del Duca, cui
chiesero di potere stare al suo servizio. Le malelingue dissero che questa
conversione politica fu dovuta ad una loro ammirazione piuttosto particolare nei
confronti del vincitore, il quale, poi, per motivi ignoti, li fece imprigionare;
l'anno dopo furono rinvenuti annegati nel Tevere.
Il 25 aprile 1501, con la
capitolazione di Faenza, Cesare Borgia completava la conquista della
Romagna.
Il 29 aprile Giovanni Bentivoglio cedeva al Valentino alcuni
castelli e un gruppo di soldati.
Nei
Discorsi sopra la prima deca di
Tito Livio, al capitolo XXXVIII del libro primo (
Le repubbliche deboli
sono male risolute e non si sanno diliberare; e se le pigliano mai alcun
partito, nasce più da necessità che da elezione), il Machiavelli, per
dimostrare la sua tesi, si ricollega a quanto avvenuto subito dopo la conquista
di Faenza.
Il Duca aveva deciso di tornare a Roma e chiese a Firenze
l'autorizzazione per poter attraversare i suoi territori. La repubblica nega il
permesso. Machiavelli considerò sbagliata questa decisione. La forza militare
del Duca era tale da potersi permettere di eludere quel divieto, come infatti
avvenne, senza che i fiorentini potessero bloccarlo; a meno di non dichiarargli
guerra. Data questa condizione il Machiavelli suggerisce che sarebbe stato più
opportuno concedere il permesso, in modo da trarre da questa decisione
legittimità e onore. Il Duca, contrariato dal divieto, si fermò sul territorio
della repubblica, che rimase per vari giorni in balìa dei suoi soldati; fino a
giugno, quando, dietro il pagamento di una forte somma di denaro, il Valentino
riprese la sua marcia.
Nel giugno 1502 vi fu una terza spedizione con
obiettivi Urbino e Camerino. Il ducato di Urbino, sostenuto in modo incerto
dagli Sforza, era governato da Guidobaldo da Montefeltro, umanista e mecenate.
Non era particolarmente attratto dalle guerre e lasciò pacificamente il suo
dominio. Nella fase che precedette la presa di Urbino, Cesare Borgia aveva
chiesto a Firenze di inviargli un ambasciatore con il quale definire la
posizione della repubblica. Fu scelto per l'incarico Francesco Soderini, vescovo
di Volterra (oltre che fratello del gonfaloniere, Piero eletto il 22 settembre
successivo) e, ad accompagnarlo, Nicolò Machiavelli. Partirono il 22 giugno, e
Machiavelli rimase fino al 26.
Nello stesso giorno scrive una lettera al
consiglio dei
Dieci della Guerra (che aveva il compito di seguire le
questioni militari, di politica estera e finanziarie collegate), nella quale
così descrive il Valentino: "
Questo signore è molto splendido e magnifico, e
nelle armi è tanto animoso che non è sì gran cosa che gli paia piccola, e per
gloria e per acquistare stato mai si riposa nè conosce fatica o periculo: giugne
prima in un luogo che se ne possa intendere la partita donde si lieva, fassi ben
volere a' suoi soldati: ha cappati e' migliori uomini d'Italia: le quali cose lo
fanno vittorioso e formidabile, aggiunte con una perpetua fortuna."
Un
mese dopo fu conquistata Camerino, il cui signore, Giulio da Varano, fu
strangolato da uomini della fazione avversa.
Nello stesso anno Cesare Borgia
si avvalse della collaborazione di Leonardo Da Vinci come architetto militare e
ingegnere capo. Questi viaggiò per dieci mesi attraverso i territori conquistati
dal condottiero: compie esami e rilevazioni, delinea alcune delle piante delle
città e le mappe topografiche (un punto di partenza per la cartografia moderna),
edifica fortezze, realizza per il porto di Cesenatico una struttura di
protezione dai flutti, costruisce macchine da guerra.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
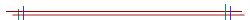 |
 |
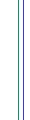 |
Machiavelli
descrive
il Borgia
come "sovrumano
nel suo coraggio"
|
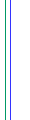 |
 |
 |
 |
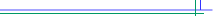 |
 |
Il
fortilizio di Imola, danneggiato dal precedente assedio, aveva necessità di
essere rafforzato. Leonardo si interessa al problema, e cominciando col
disegnare la nuova sistemazione interna della rocca, finisce per tracciare
l'intera pianta della città.
Era il momento di più alta potenza del Duca, i
cui successi ormai facevano venire gli incubi ad altri stati nella penisola
italiana: Venezia guardando la costa adriatica italiana ormai vedeva quasi
soltanto domini pontifici; Firenze doveva considerare la eventualità che il
Valentino puntasse a conquistare, in modo sistematico, la Toscana.
Nonostante
questa evenienza fosse osteggiata da Luigi XII, Firenze decise comunque di
verificare le intenzioni del Valentino.
Il 6 ottobre 1502 Nicolò Machiavelli
parte per compiere la legazione, poi divenuta celebre, presso Cesare Borgia.
Inizia subito a inviare lettere ai suoi interlocutori istituzionali a Firenze
scrivendo in merito alle prime conversazioni con il Valentino.
In una lettera
dell'11 ottobre, Nicolò Valori scrive al segretario fiorentino che le sue
relazioni dei giorni 7-8-9, nelle quali descrive il Valentino, sono state
apprezzate per la precisione e la chiarezza. Nella stessa lettera il Valori
chiede al Machiavelli di far uscire allo scoperto il Duca a proposito delle
intenzioni nei confronti della repubblica fiorentina, ricollegandosi ad un passo
della lettera del 7-8 ottobre nella quale Machiavelli dice che il Borgia, in
merito alla possibilità di stringere una lega con Firenze, "
sempre girò
largo". Inoltre il Valori attende dal Machiavelli una valutazione sul ruolo
che la Francia intende svolgere nella penisola e sul rapporto tra questo stato e
il Valentino; augurandosi che la alleanza tra loro giovi a Firenze.
Il 9
ottobre 1502 Cesare Borgia conquista Fano, alla cui popolazione, come
riconoscimento per la alleanza, dona il castello di Montefelcino (Pesaro), che
sorgeva il una posizione strategica vicino al confine con la Romagna.
Al
consiglio dei
Dieci di Guerra, Machiavelli descrive il Duca come
"
sovrumano nel suo coraggio" e "
capace di ottenere tutto ciò che
voleva", uno che "
doveva essere considerato come un nuovo potente in
Italia"; osservazioni che poi sviluppa nel cap. 7 de
Il
Principe.
Il dialogo epistolare tra il Valori e Machiavelli
prosegue con una lettera del 23 ottobre, che il primo invia al segretario per
informarlo sia dell'apprezzamento in merito alla qualità delle relazioni sul
Duca, sia di due iniziative che la repubblica ha intrapreso con la speranza che
incontrino il favore del Valentino. La prima è l'invio a Roma di Alessandro
Bracci (o Braccesi) in qualità di oratore, al posto di Giovan Vittorio Soderini.
La seconda decisione presa è l'invio di alcuni ufficiali a Borgo San Sepolcro,
al fine di rafforzare i confini di Firenze e al tempo stesso di arrecare
vantaggi tattici ai movimenti delle truppe del Borgia.
Ma accanto alle
dimostrazioni di apprezzamento, il Machiavelli riceve anche qualche
contestazione.
In una lettera del 28 ottobre, Biagio Buonaccorsi, suo
coadiutore alla cancelleria, critica il Machiavelli poiché, gli scrive, le sue
relazioni sul Valentino giungono ogni otto giorni; un periodo di tempo ritenuto
troppo lungo data l'importanza della questione. Soprattutto il Buonaccorsi
scrive di non approvare le conclusioni del segretario a proposito della potenza
di Cesare Borgia, che ritiene sopravvalutata; con riferimento a quanto il
Machiavelli ha scritto nelle lettere del 9-15-23 dello stesso mese.
In
questa lettera, il tono della contrapposizione del Buonaccorsi è tale che egli
scrive al Machiavelli di non attendersi alcuna risposta da parte sua.
Per
curiosità, è dello stesso giorno, una lettera di Nicolò Valori, il quale rinnova
le congratulazioni al Machiavelli per la sua opera presso il Valentino.
Il 7
novembre Marcello Virgilio scrive a Machiavelli invitandolo a proseguire la sua
legazione presso il Duca (che si apprestava a spostarsi verso Rimini), data la
incertezza sulla scelta di colui che avrebbe dovuto sostituirlo.
 |
Giuliano della Rovere, che
divenne
papa col nome di Giulio II |
Il 14
novembre il gonfaloniere di Firenze, Piero Soderini, scrive a Machiavelli la sua
approvazione alla collaborazione con il Valentino, e gli chiede una valutazione
a proposito dei soldati che Firenze dovrebbe inviare in sostegno del Duca,
rilevando come la città sia ben disposta nei suoi confronti. Inoltre lo informa
di aver incaricato suo fratello Francesco, vescovo di Volterra, oratore presso
la corte francese, di chiedere al sovrano che non si ostacoli la convergenza tra
il Valentino e la repubblica fiorentina.
Ma il 15 novembre Biagio Buonaccorsi
scrive ancora una volta al Machiavelli una lettera nella quale gli ribadisce che
non deve illudersi di compiacere il Valentino.
Il 28 novembre Piero Soderini
conferma la sua approvazione sul lavoro svolto dal Machiavelli, chiedendogli di
rimanere ancora presso il Valentino.
Il 7 dicembre esprime la sua
soddisfazione per le buone intenzioni del Duca nei confronti Firenze, che decide
di ricambiare non autorizzando il vescovo di Urbino, Gian Piero Arrivabene, a
soggiornare in città.
Il 21 dicembre terza lettera del gonfaloniere che
rinnova a Machiavelli l'invito a rimanere presso il Valentino.
Cesare Borgia
parve a Machiavelli in possesso oltre che delle capacità militari anche di
qualità politiche tali da permettergli la creazione di un suo stato, e per
svilupparne una analisi più articolata chiese a Biagio Buonaccorsi una copia
delle
Vite di Plutarco, per cercare elementi comparativi con la figura
del condottiero.
La legazione presso il Valentino permise al Machiavelli di
constatare anche la qualità dei suoi luogotenenti. Quando nel dicembre 1506
viene nominato segretario dei
Nove della milizia della repubblica
fiorentina, con l'incarico di organizzare un esercito composto da cittadini,
egli suggerisce al gonfaloniere di scegliere i soldati tra i contadini e di
affidarne il comando a don Miguel de Corella, soldato catalano dell'esercito di
Cesare Borgia.
La paura di essere travolti dal Valentino riguardò, oltre i
suoi avversari, anche alcuni personaggi arruolati nella sua parte. Tra loro,
Vitellozzo Vitelli convocò un
summit presso il castello della Magione,
sul lago Trasimeno (Perugia), di proprietà del cardinale Orsini. Vi
parteciparono anche i Bentivoglio, i Baglioni, Pandolfo Petrucci e Oliverotto da
Fermo.
Una alleanza che Biagio Buonaccorsi, nella lettera del 28 ottobre,
invita il Machiavelli a non sottovalutare (e che ebbe come primo effetto la
perdita di Urbino, in cui ritorna al potere Guidobaldo). Insieme concordarono
una strategia finalizzata alla dichiarazione di guerra nei confronti del
Valentino e - dopo avergli sottratto il titolo di duca di Romagna -
alla restituzione dei territori conquistati ai dominatori precedenti. Per
arrivare a questo obiettivo contavano di svolgere una azione di propaganda per
far perdere consenso popolare al Borgia e un appello alla diserzione per i
soldati del suo esercito. Il Valentino prese sul serio la questione e chiese
aiuto al padre, il quale, almeno dal punto di vista finanziario, proprio in quel
momento, poteva dargliene ben poco, poiché le casse pontificie erano quasi
vuote. Iniziata comunque una trattativa con i nemici del figlio, Alessandro VI
mise all'asta benefici ecclesiastici (pratica che provocherà poi le ire di
Lutero) e, insieme con l'eredità del cardinale Ferrari di cui si era
impossessato, riuscì ricavare circa cinquantamila ducati, che, girati a Cesare,
servirono per arruolare seimila soldati mercenari.
La congiura a quel punto
non giunse a nulla e dopo un incontro preliminare tra Paolo Orsini e il Borgia,
a Imola il 25 ottobre 1502, si decise di stipulare una pace, con una riunione
nella serata tra il 31 dicembre e l'1 gennaio del 1503 a Senigallia (provincia
di Ancona). Da una parte c'era Cesare Borgia, dall'altra Vitellozzo Vitelli,
Oliverotto da Fermo, Paolo e Francesco Orsini.
Dalle lettere inviate al
consiglio dei
Dieci, si nota come Machiavelli avesse intuito che
quell'incontro si sarebbe potuto concludere in modo inaspettato.
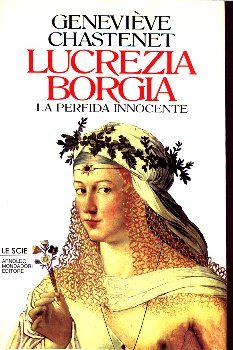 |
In questa biografia la sorella
di
Cesare viene presentata come
perfida |
Mentre si stava svolgendo la
riunione, che sembrava ormai conclusa con la firma di un patto di
confederazione, venne dato un segnale; nella sala entrarono le guardie del
Borgia, arrestarono i suoi avversari e li imprigionarono. Oliverotto da Fermo e
Vitellozzo furono strangolati quella stessa notte. I due Orsini vennero
condannati a morte il 18 gennaio 1503.
Machiavelli al ritorno dalla sua
missione consegnerà alla storia la cronaca di quell'episodio nella
Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo
Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini,
considerandola "
impresa rara e mirabile".
Il Duca riprese il
controllo dei territori laziali (i cui principi si erano schierati con Giulio
Orsini), conquista la repubblica di San Marino, e riconquistata anche Urbino,
nonostante il suo signore, Guidobaldo, avesse fatto distruggere le rocche di
Gubbio e Pergola per accentrare tutte le forze in difesa della città.
Cesare
Borgia era al massimo della celebrità. A Fano viene pubblicata una edizione
delle
Opere di Petrarca con una dedica a Cesare Borgia.
Un giorno di
agosto, lui e il padre furono invitati a cena dal cardinale Corneto, in una
villa vicino al Vaticano. Pochi giorni dopo i due Borgia ebbero febbre alta e
vari malori; si pensò che avessero messo del veleno nel cibo poi, per errore,
mangiato da loro stessi. Non era così, perché il vero motivo di quella
debilitazione era la malaria, che si stava diffondendo a Roma. Alessandro VI
morì il 18 agosto e Cesare, pur debilitato, dovette fronteggiare le azioni dei
suoi avversari.
Il pericolo maggiore arrivava dalla Romagna, dove i suoi
nemici avevano ottenuto l'appoggio di Venezia, che iniziava a inviare le proprie
truppe e occupare parti di territorio. Inoltre c'era da gestire un conclave che
si presentava determinante per la sua sorte, e al quale fu invitato anche
Machiavelli.
Il 2 settembre 1503, al primo tentativo, grazie all'appoggio
dei cardinali spagnoli, riuscì a fare eleggere pontefice il cardinale Francesco
Piccolomini, con il nome di Pio III, bloccando il suo potente concorrente: il
cardinale Della Rovere. Ma Pio III, che lo aveva confermato capitano generale
della Chiesa, muore ventisette giorni dopo. Di nuovo Cesare dovette affrontare
il Della Rovere il quale però, al secondo tentativo, ebbe partita vinta, e l'1
novembre divenne papa con il nome di Giulio II.
Il Borgia, constatando
l'impossibilità di rifare un fronte comune contro di lui, ritenne più funzionale
cercare una trattativa, che gli permise, al momento, di conservare il titolo di
duca di Romagna e il comando dell'esercito pontificio.
Il 15 novembre Biagio
Buonaccorsi scrive a Machiavelli. Dopo avergli espresso il proprio parere
sull'assalto di Venezia ai territori del Valentino - che aveva portato alla
conquista di Rimini e Faenza - lo informa dei cambiamenti dell'opinione pubblica
fiorentina, adesso contraria al Borgia. Il motivo sarebbe soprattutto il
contrasto con il nuovo Papa e la possibilità che nello diatriba tra i due, sia
il Duca nelle condizioni peggiori. Tanto che nella riunione tra gli
Ottanta (magistratura con funzioni di senato, intermedia tra la
Signoria e il
Consiglio Grande) e un certo numero di cittadini
la proposta di dare al Valentino un salvacondotto, per attraversare i territori
della repubblica, è respinto da circa novanta dei votanti contro circa venti a
favore.
Il Buonaccorsi scrive che questa fase negativa del condottiero
potrebbe smontare quella valutazione entusiasta, fondata sulla sua audacia, data
dal Machiavelli, e prosegue insinuando che qualcuno comincia a credere che i
suoi apprezzamenti alle qualità del Valentino siano mossi dalla speranza di
ottenere da lui qualche ricompensa. Ad ogni modo - prosegue nella lettera il
Buonaccorsi - ogni congettura è inutile poiché non si tratta più, per i
fiorentini, di essere a favore oppure no del Valentino, ma stabilire cosa fare
contro di lui.
La decisione del Valentino di accordarsi con il nuovo papa fu
considerata dal Machiavelli come una ingenuità. Infatti Giulio II - passato alla
storia perché più dedito alle guerre e al mecenatismo (per lui lavorarono
Michelangelo, Raffaello, Bramante) che alla redenzione delle anime - non
conferma quell'accordo e ordina al Borgia di rinunciare al suo titolo di Duca e
cedere la Romagna allo stato pontificio. Al suo rifiuto, lo fa arrestare. Il
Valentino viene liberato soltanto quando rinuncia alle condizioni stabilite
durante l'elezione pontificia.
Subito si reca a Napoli, presso Consalvo di
Cordova, dove cerca di formare un suo esercito per tentare una rivalsa e salvare
ciò che resta dei suoi domini, i quali ormai si riducono alla unica Forlì.
Informato, Giulio II chiese al re Ferdinando di arrestarlo. Il re obbedisce e lo
fa deportare in Spagna, dove rimase in prigione, nel castello di Chinchilla, per
due anni, fino al novembre 1506, quando riesce a evadere e a riparare a
Pamplona, presso la corte di Navarra, dove regnava Giovanni d'Albret, fratello
di sua moglie Carlotta, il quale gli diede il titolo di
condestable della
Navarra, e il comando di un esercito da lanciare contro un suo vassallo,
Juan di Beaumont.
Il 12 marzo 1507 a Viana (a 81km da Pamplona) durante
l'attacco alla fortezza del nemico, Cesare Borgia fu ferito a morte.